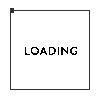Pearl Jam
-
1. Life Wasted 3:52
-
2. World Wide Suicide 3:28
-
3. Comatose 2:20
-
4. Severed Hand 4:28
-
5. Marker In The Sand 4:22
-
6. Parachutes 3:35
-
7. Unemployable 3:03
-
8. Big Wave 2:56
-
9. Gone 4:08
-
10. Wasted Reprise 0:52
-
11. Army Reserve 3:42
-
12. Come Back 5:26
-
13. Inside Job 7:08
Quando una band sceglie di non dare un titolo ad un proprio disco – o, meglio, quando lo titola con il proprio nome – non è per mancanza di idee, ma per lo più per affermare la propria identità. Sicuramente questo è il caso di “Pearl jam”, l’album del 2006 della band di Seattle – conosciuto anche come “Avocado”, per via del frutto in copertina.
I Pearl Jam, nel periodo 2000-2006 vivono un’altra fase intensa della loro storia. Nel 2002 esce “Riot act”, album con cui la band fa i conti con la tragedia di Roskilde (9 persone morte durante un loro concerto del 2000, per la calca: “Love boat captain” è la loro reazione in musica) e con l’America post-11 settembre (il titolo è un gioco di parole con il Patriot Act, la legislazione di controllo introdotta dal governo con la scusa della lotta al terrorismo).
Negli anni successivi la band si butta sui concerti, pubblicando gli ormai consueti bootleg ufficiali, ma anche un disco dal vivo “regolare” (l’acustico “Live at Benaroya Hall”, registrato nella natia Seattle) e la raccolta di rarità “Lost dogs”.
Nel 2005 la band pensa, dopo tre anni, a nuova musica. Entra in studio a Seattle, con Adam Kasper, già al lavoro sul disco precedente. Per la prima volta si mette ad incidere senza canzoni già pronte, solo qualche idea. Ci metterà quasi un anno a completare il lavoro – sia perché nel frattempo continua ad andare in tour, sia perché Vedder diventa padre.
Ma da quelle sessioni escono quasi 30 canzoni, di nuovo scritte a più mani. Delle 13 finali, Vedder è autore solo di quattro, co-autore di due. Le altre escono dalla penna degli altri membri: lo stile collaborativo di scrittura iniziato nei dischi precedenti viene mantenuto. Vedder è autore invece dei testi, come sempre.
Il risultato è un disco che esce a marzo del 2006 e che viene salutato da molti recensori del tempo come un ritorno alle origini: “I Pearl Jam non sono stati così diretti e sporchi nello studio dal ’95, da quando incisero ‘Mirror ball’ con Neil Young”, scrive Rolling Stone.
Ma “Pearl Jam” non è un disco retrospettivo. E’ un altro pugno nello stomaco, dopo “Riot act”. Da digerire c’è l’elezione presidenziale persa nel 2004, quella che ha riconfermato George W. Bush, e che i Pearl Jam avevano cercato a loro modo di influenzare con il tour “Vote for change” assieme a Springsteen e R.E.M. nel 2004.
La carica di “Pearl jam” è meno rabbiosa di “Riot act”, ma non meno potente. E’ una rabbia, se vogliamo, più meditata. Si sente che i Pearl Jam sono partiti dalle chitarre, entrano in studio con poche cose se non qualche riff: quello, stupendo, di “Marker in the sand”, o quello di “Comatose”, o il singolo “Worldwide suicide”, il cui titolo la dice lunga sulla visione di Vedder e sul fatto che, neanche questa volta, voglia occuparsi d’altro che non sia la situazione disastrata del suo paese (e del resto del globo). Addirittura, i Pearl Jam recuperano le origini punk, già evidenti in molte delle cover suonate dal vivo negli anni precedenti. E poi virano alla melodia: “Come back”, quasi soul, o la conclusiva “Inside job” o ancora “Gone”.
Il disco viene pubblicato per la Sony, nonostante il gruppo abbia ormai terminato il proprio contratto nel 2003: firmano un accordo con la J Records di Clive Davis, parte del gruppo della multinazionale: i bootleg li pubblicano da soli, ma continuano ad avere il bisogno del supporto di una casa discografica.
E funziona: il disco li riporta in top 10, vendendo più del precedente. Poi, come al solito, la band torna in tour: a settembre del 2006, ben 5 date in Otalia, da cui verrà tratto un documentario, “Immagine in cornice”, come quella “Picture in a frame” di Tom Waits, dedicata da Vedder a Milano alla compagna Jill McCormick, nella città in cui l’ha conosciuta.