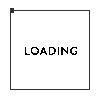Dirty Deeds Done Dirt Cheap
-
1. Dirty Deeds Done Dirt Cheap 3:46
-
2. Love at First Feel 3:05
-
3. Big Balls 2:39
-
4. Rocker 2:46
-
5. Problem Child 5:43
-
6. There’s Gonna Be Some Rockin' 3:14
-
7. Ain’t No Fun (Waiting Round to Be a Millionaire) 6:57
-
8. Ride On 5:47
-
9. Squealer 5:12
La storia del rock è incredibilmente piena di cantonate. Pessime scelte fatte da chi, pur avendo il privilegio di poter prendere decisioni importanti agisce senza aver compreso appieno un fenomeno o un artista. Di solito il tempo, poi, fa giustizia e punisce – più o meno metaforicamente – i responsabili… ma il fatto resta, con tutti gli annessi, i connessi e gli eventuali danni causati da gesti non ponderati o guidati da logiche errate.
È il caso di “Dirty Deeds Done Dirt Cheap”: il terzo disco inciso, in ordine cronologico, dagli AC/DC, pubblicato in Australia nel settembre del 1976, ma – incredibilmente – rifiutato dalla Atlantic che avrebbe dovuto farlo uscire negli USA e aiutare la band a sfondare in quel mercato all’epoca ancora ostico per Angus Young e compari.
A complicare ulteriormente il quadro interviene la decisione di cambiare, per l’uscita nei mercati extra-australiani, la tracklist: per cui nella stessa annata si trovano in commercio due versioni differenti dello stesso lavoro. Una australiana e una per il resto del mondo (USA esclusi, che il disco lo intravedono solo come import, in quantità limitate e a prezzi elevati).
“Dirty Deeds Done Dirt Cheap”, nel 1976, è un album intrinsecamente delinquenziale, maleducato, rozzo, inaccettabile per una certa fetta di benpensanti del rock tradizionale – ancora legati alle sonorità pre-esplosione del punk e che non disdegnano incursioni nei lidi raffinati (o semplicemente pomposi) di certo prog e rock poppeggiante. Il suo bello è proprio questo: si tratta di un lavoro deliziosamente lontano da qualsivoglia forma di raffinatezza, che mostra al mondo quanto liberatorie e divertenti possano essere la mancanza di sensibilità, l’assenza di tatto e zero buon gusto nelle accezioni legate al comune senso del pudore… qui si va al sodo e tutto evoca sesso, donne, divertimento stradaiolo, atteggiamento strafottente e – ovvio – l’immancabile campionario di alcool e alterazione mentale. Un problema che è anche un punto di forza, perché i rocker più intransigenti e il pubblico del rock, in effetti, dimostrano di volere proprio questo, all’atto pratico. E gli AC/DC sanno perfettamente rispondere a questa esigenza. Però la grande discografia made in USA non è ancora pronta a gestire un simile fenomeno; e infatti la Atlantic si risolve a commercializzare “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” con i sacri crismi negli USA – con la tracklist internazionale, non quella australiana – solo cinque anni dopo l’uscita vera e propria, ovvero dopo la pubblicazione del fortunatissimo “Back in black” (quindi con Brian Johnson già in formazione, essendo morto il mitico Bon Scott, che invece canta nell’album in questione)… ed è un’operazione che si rivela un successo.
Un successo dal sapore non proprio dolce, se si pensa che tutto avrebbe potuto accadere con un lustro di anticipo e – chissà – forse le cose sarebbero andate diversamente per Bon Scott, che magari sarebbe ancora fra noi. Ma non è giusto perdersi nei meandri dei “what if”: gli eventi sono inoppugnabili e non possono essere cambiati. Punto.
“Dirty Deeds Done Dirt Cheap” probabilmente non è uno dei grandi classici più noti e gettonati degli AC/DC, ma è senza il minimo dubbio uno dei loro album più pericolosi, tesi e ispirati: i nove pezzi dell’edizione internazionale sono un concentrato di sudore, atmosfere da bar malfamato, vicoli poco illuminati dove cercare (e trovare) rogne, situazioni pericolose… ma anche sesso, goliardia, voglia di fare casino e tanta smania di arrivare al successo. La colonna sonora per queste storie – narrate da Bon Scott con i suoi tipici testi ironici, taglienti, pieni di doppi sensi e giochi di parole che si rincorrono – è un hard rock’n’roll bluesato ad altissimo voltaggio, a tratti metallico, che cattura e non molla l’ascoltatore finché l’eco dell’ultima nota non si è spento. Pura eccitazione da adrenalina, tanto che, col proverbiale senno di poi, risulta incomprensibile come la Atlantic abbia – nel 1976 – bollato l’album come derivativo, statico, poco interessante e mediocre, incolpando peraltro il buon Scott in maggior misura (tanto che, stando alle famose voci di corridoio, i vertici dell’etichetta erano convinti che il cantante sarebbe stato licenziato dopo questa performance).
Invece qui troviamo brani come l’inno “Rocker”, la lenta e minacciosa “Ride on”, l’autobiografica “Problem child” – per non parlare della title track, laida, sguaiata e potente come un diretto in pieno viso, a sorpresa: materiale di prima qualità.
Se mai vi venisse in mente di provare ad afferrare il concetto di rock’n’roll nella sua essenza più incontaminata e nobile, “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” sarà uno degli strumenti di cui avrete bisogno. Necessariamente.